DURKHEIM E L'EDUCAZIONE NELLA SOCIETA' - Come la pedagogia diventa uno strumento di trasmiss
- 6 nov 2017
- Tempo di lettura: 5 min
Emile Durkheim è stato un sociologo vissuto in Francia a cavallo tra il XIX e il XX secolo, nonché uno dei padri della sociologia, grazie alla sua rivista 'L'année sociologique', di cui è stato direttore fino al 1910. Ha insegnato sociologia presso l'università 'Sorbonne' di Parigi.
<<L'educazione consiste in una socializzazione metodica delle giovani generazioni. In ciascuno di noi, si può dire, esistono due esseri che, pur essendo separabili solo per astrazione, restano nondimeno distinti. L'uno è gatto di tutti gli stati mentali che si rapportano solo a noi stessi ed agli eventi della nostra vita personale: è ciò che si potrebbe chiamare l'essere individuale. L'altro è un sistema di idee, di sentimenti e di abitudini che esprimono in noi non già la nostra personalità, bensì il gruppo o i gruppi differenti di cui facciamo parte; tali sono le credenze religiose, le credenze e le pratiche morali, le tradizioni nazionali o professionali, le opinioni collettive di ogni tipo. Il loro insieme forma l'essere sociale. Costituire questo essere in ciascuno di noi: questo è il fine dell'educazione.
E' da qui, del resto, che meglio si mostra l'importanza del suo ruolo e la fecondità della sua azione. Infatti questo essere sociale non solo non è dato già fatto nella costituzione primitiva dell'uomo; ma non ne è neppure risultato attraverso uno sviluppo spontaneo. Spontaneamente l'uomo non è incline a sottomettersi a un'autorità politica, a rispettare una disciplina morale, a votarsi al sacrificio. Non c'era niente nella nostra natura congenita che ci predisponesse necessariamente a diventare servitori di divinità, emblemi simbolici della società, a render loro un culto, a imporci privazioni in loro onore. La società stessa via via che si è formata e consolidata, ha tratto dal proprio seno queste grandi forze morali davanti alle quali l'uomo ha sentito la sua inferiorità.
Ora, se si fa astrazione dalle vaghe e incerte tendenze che possono esser dovute all'ereditarietà il fanciullo, entrando nella vita, vi porta solo la sua natura d'individuo. La società si trova dunque, a ciascuna nuova generazione, in presenza pressoché di una tabula rasa sulla quale deve ricostruire tutto di fondo. E' necessario che, attraverso le vie più rapide, all'essere egoista e asociale che è appena nato, essa ne sovrapponga un altro, capace di condurre una vita morale e sociale. Ecco qual è l'opera dell'educazione: e se ne scorge tutta la grandezza. Non si limita a sviluppare l'organismo individuale nel senso segnato dalla sua natura, a rendere evidenti potenzialità nascoste che chiedevano solo di rivelarsi. Essa crea nell'uomo un essere nuovo.
Tali virtù creatrice è, del resto, un privilegio speciale dell'educazione umana. Del tutto diversa è quella che ricevono gli animali, se è lecito chiamare con questo nome l'allenamento progressivo al quale i loro genitori li sottomettono. Essa può certo accelerare lo sviluppo di certi istinti che sonnecchiano nell'animale, ma non lo inizia a una vita nuova. Facilita il giuoco delle funzioni naturali, ma non crea nulla. Istruito da sua madre, il piccolo impara più in fretta a volare o a fare il nido; ma non apprende niente che non potesse scoprire attraverso la sua esperienza personale. Il fatto è che gli animali o vivono al di fuori di qualsiasi stato sociale, o formano società abbastanza semplici, funzionanti grazie a meccanismi istintivi che ciascun individuo porta dentro di sé, già costituiti, fin dalla nascita. L'educazione non può dunque aggiunger nulla d'essenziale alla natura, dato che quest'ultima basta a tutto alla vita del gruppo così come a quella dell'individuo.
Nell'uomo, invece, le attitudini di ogni tipo presupposte dalla vita sociale sono di gran lunga troppo complesse per potersi incarnare, in qualche modo, nei nostri tessuti e materializzarsi sotto la forma delle predisposizioni organiche. Ne consegue che non possono trasmettersi da una generazione all'altra per via ereditaria. E' per mezzo dell'educazione che avviene la trasmissione.
Siamo così in grado di rispondere a una domanda sollevata da tutto ciò che precede. Mentre mostravamo la società formare, secondo i suoi bisogni, gli individui, poteva sembrare che questi ultimi subissero per questo fatto una insopportabile tirannia. Ma, in realtà, questa sottomissione è nel loro stesso interesse, perché l'essere nuovo che, attraverso l'educazione, è così edificato in ciascuno di noi, rappresenta quanto di meglio c'è in noi, quanto c'è in noi di propriamente umano, L'uomo, infatti, è uomo solo perché vive in società. E' difficile, nel corso d'un articolo, dimostrare con ricorre un'affermazione tanto generale e tanto importante, che riassume il lavoro della sociologia contemporanea. Ma, anzitutto, si può dire che essa è sempre meno contestata, per di più non è impossibile richiamare sommariamente i fatti più essenziali che la giustificano.
Prima di tutto, se c'è oggi un fatto storicamente accertato, è quello che la morale si trova strettamente in rapporto con la natura delle società, poiché, come abbiamo visto strada facendo, cambia quando cambiano le società. Risulta dunque dalla vita in comune. E' la società, infatti, che ci trae fuori da noi stessi, ci obbliga a fare i conti con interessi diversi dai nostri, ci insegna a dominare le passioni, gli istinti, a imporre loro una legge, ad assoggettarci, a imporci privazioni, a sacrificarci, a subordinare i nostri fini personali a fini più alti. E' la società ad aver istituito nelle nostre coscienze l'intero sistema di rappresentazioni che sostiene in noi l'idea e il sentimento della regola, della disciplina, tanto interna quanto esterna. E' così che noi abbiamo acquisito quel potere di resistere a noi stessi, quella padronanza sulle nostre inclinazioni che è uno dei tratti distintivi della fisionomia umana e che è tanto più sviluppata quanto più siamo pienamente uomini. Non dobbiamo meno alla società dal punto di vista intellettuale. E' la scienza che elabora le nozioni basilari dominanti nel nostro pensiero: nozioni di causa, di legge, di spazio, di numero; nozioni riguardanti i corpi, la vita, la coscienza, la società, ecc. Tutte queste idee fondamentali sono in perpetua evoluzione: sono il compendio, la risultante di tutto il lavoro scientifico, lungi dall'esserne il punto di partenza come credeva Pestalozzi. Noi non ci rappresentiamo l'uomo, la natura, le cause, lo spazio stesso come se li rappresentavano nel Medioevo; e questo perché le nostre conoscenze e i nostri metodi scientifici non son più gli stessi. Ora, la scienza è un'opera collettiva, poiché presuppone una vasta cooperazione di tutti gli studiosi non solo di uno stesso tempo, ma di tutte le epoche succedentisi nella storia.
Prima che le scienze fossero costituite, la religione ricopriva lo stesso ufficio, dato che qualsiasi mitologia consiste in una rappresentazione, già molto elaborata , dell'uomo e dell'universo. La scienza, del resto, è stata l'erede della religione. Ora, una religione è un'istituzione sociale.
Imparando una lingua, apprendiamo un intero sistema d'idee, distinte e classificate, ed ereditiamo tutto il lavoro da cui sono uscite queste classificazioni, che riassumono secoli d'esperienze. C'è di più: senza il linguaggio non avremmo, per così dire, idee generali, dato che è la parola a dare ai concetti, fissandoli, una consistenza sufficiente perché possano esser maneggiati comodamente dallo spirito. E' il linguaggio, dunque, che ci ha permesso di elevarci al di sopra della pura sensazione; e non c'è bisogno di dimostrare che il linguaggio è, massimamente, cosa sociale.>>
Durkheim fonda la sua idea di educazione su due concetti fondamentali: ogni processo cognifivo deve evitare di fare astrazione nella realtà sociale, la società ha il primato sull'individuo.
Nel testo, il sociologo enuncia uno dei principi fondamentali della cultura liberale ed imborghesita: l'uomo viene educato in funzione della società nella quale esso stesso vive. L'io individuale qui diventa un io sociale, ovvero capace di comprendere e condividere delle leggi e delle norme di tipo etico che regolano la vita associata. Da qui la tesi dell'educazione come socializzazione.
Articolo di Emile Durkheim, trascitto e curato da Davide Fassola

















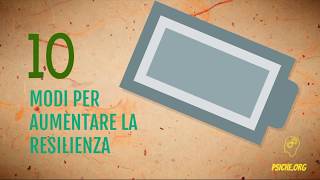
Commenti