Le affinità di tutti gli educatori
- 2 ott 2017
- Tempo di lettura: 3 min
Duccio Demetrio, il cui nome non vi sarà nuovo se siete da tempo lettori degli articoli di Help Psicologia, collabora da tempo sui testi scolastici di pedagogia e di psicologia.
Il brano che vi proponiamo oggi è tratto dalla sua opera 'Educatori di Professione', del 1990, edito da La Nuova Italia, testo che consigliamo a chi volesse approfondire. Il testo che proponiamo oggi è parziale e pubblicato senza scopo di lucro (come del resto tutte le attività che si svolgono sul nostro sito).
Demetrio è docente di pedagogia generale e di educazione degli adulti alla Bicocca di Milano, esperto di filosofia e di psicologia, lavora da tempo sul settore dell'autobiografia ed è anche rettore dell'università libera di Anghiari.
In questo brano si evidenzia la figura dell'educatore, e di come quest'ultimo può innescare le dinamiche relazionali capaci di suscitare il rinnovamento dei rapporti individuale, oltre che il transito delle emozioni, e favorire l'apprendimento. L'obiettivo è chiaramente la trasformazione cognitiva e psichica dell'alunno.
Il lavoro sociale: l'educatore (e qui potremmo includere anche coloro che non svolgono la professione: insegnanti, genitori, formatori, assistenti sociali, ecc.) svolge un'attività che contribuisce alla riproduzione, al controllo ma anche all'emancipazione sociale degli individui.
E' un lavoro che deve soddisfare, intenzionalmente, bisogni e, senza il quale, il livello di sviluppo della società civile, la cultura dei <<diritti degli altri>>, i rapporti di convivenza ed integrazione ne risulterebbero fortemente compromessi.
Il suo lavoro è socialmente utile anche quando la comunità sociale non gli riconosce, o non si accorge di questo, un ruolo istituzionale definito. L'educatore, qualunque educatore, lavora poi per chi non è autosufficiente: non può ancora esserlo, non lo è più, non ha mai potuto, o voluto, esserlo.
Il lavoro educativo: come abbiamo visto, per definirsi educatori distinguendosi in questo da altri operatori sociali, è necessario organizzare <<un fare>> che metta gli altri nelle condizioni di modificare nel breve o lungo periodo la rappresentazione, il concetto, l'opinione di sé. Perché il lavoro educativo, attraverso le sue didattiche e le condizioni in cui esse hanno luogo, produce, metableticamente (Relativamente al cambiamento che si produce nel processo educativo. Dal greco: cambiare, ndc), una trasformazione nelle esistenze, nei saperi, nei saper fare degli individui e dei gruppi.
Il lavoro pedagogico: un educatore può dirsi, anche, operatore pedagogico, se ha ricevuto una preparazione attinente alle scienze dell'educatore (…) ed è in grado pertanto di programmare, organizzare, verificare la sua attività.
Naturalmente, c'è da augurarsi che queste figure possano avere tutte una formazione a livello universitario; al momento attuale è auspicabile, perché il lavoro educativo sia pedagogicamente orientato, che, almeno, possano venire sempre garantite le condizioni per una formazione in servizio o momenti preliminari di studio e ricerca sulle realtà nelle quali l'operatore verrà inserito.
Le implicazioni esistenziali: l'educatore ha a che fare, quotidianamente o meno, con il malessere sociale o la sofferenza psichica e relazionale, con i bisogni di realizzazione.
Vive quindi, e ne è coinvolto talvolta al limite della resistenza psicofisica, le tensioni di protezione, accudimento, rassicurazione, conferma, incoraggiamento); della aggressività ( di fronte alla devianza, alla dissociazione psichiatrica, alla tossicodipendenza, al pregiudizio sociale, ecc.): della cronicità e del declino (lavorando con l'handicap, la terza età, le malattie terminali).
Le implicazioni, certamente, differiscono da situazione a situazione, comunque esse si alternano, si enfatizzano, si stabilizzano attorno a queste tre aree. Perché l'educatore o riesce a elaborarle giorno per giorno o va incontro ad esse – cerca di individuarle e circoscriverle – per attenuarne gli esiti devastanti per gli individui che ne sono portatori.
Le discussioni relazionali: poiché il lavoro educativo e pedagogico si fondano sul lavoro sociale, essi sono giocoforza basati sulla relazione con l'altro. Gli educatori istituzionali o territoriali, quindi, pur distanti per ciò che concerne i tempi di << esposizione alla relazione >> rispetto ad individui e gruppi (continuativa e full-time per i primi, part-time e discontinua per i secondi=, intrattengono relazioni
-con l'utenza;
-per l'utenza;
-per il servizio o il progetto.
Nel primo caso (…) lo scambio e il contatto divengono il vero oggetto del lavoro; mediato sempre dai contenuti delle didattiche relazionali (ci si mette in relazione con l'utenza per sviluppare le diverse intelligenze, introdurre in essi novità, integrarle fra loro=; nel secondo, gli educatori allestiscono, preparano, organizzano le condizioni perché la relazione si compia nel miglior modo possibile; nel terzo, infine, essi partecipano alla gestione del servizio e, qui, la relazione si sposta dall'utenza a tutti coloro che gestiscono, intervenendovi a diverso titolo, il processo educativo; che, quasi sempre, richiede anche l'espletamento di momenti relazionali con i co-interessati all'azione educativa: famiglia, altri operatori, amministratori, ecc.
Nota finale del curatore
L'elemento di novità che porta Demetrio nel settore dell'educazione è proprio il compito dell'educatore, non più soltanto sul piano pedagogico ma anche sul piano educativo, e soprattutto su quello sociale. Altro elemento importante presentato dall'autore è proprio quello della 'metabletica' del fattore dinamico nell'insegnamento.

















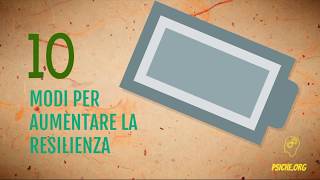
Commenti