Purezza e pericolo
- 26 ago 2017
- Tempo di lettura: 8 min
Qualcosa chiamato istinto. Ecco cosa convince una casalinga a fare le pulizie in casa. Un impulso mosso dalle norme igieniche comunemente diffuse in società: rimodellare il proprio ambiente di modo da renderlo vivibile. Ciò che è sporco, almeno nella mentalità della casalinga è qualcosa che non si può inserire nella sua casa ed è dunque fuori posto.
Ebbene, ogni cultura deve rapportarsi con quelle che sono le anomalie che minano la sicurezza delle basi di quello stile di vita culturale stesso. La purezza e le sue regole hanno un ruolo centrale per comprendere anche la religione e ciò che è rituale, nonché i tabù diffusi nella società: una tale ricerca può aiutarci a capire il perché di molte norme diffuse nella nostra società(e in quelle altrui).
Mary Douglas è una esponente dello strutturalismo antropologico inglese(creato da Evans Pritchard) e ha studiato filosofia, economia e politica presso l’Università di Oxford. Per alcuni anni ha lavorato nel Congo Belga per svolgere ricerche sul campo. Ha poi insegnato presso l’University College di Londra. Le sue più famose pubblicazioni sono “The Lele of the Kasai” e “Natural simbols”, nonché il libro che espone ben più approfonditamente l’argomento che oggi trattiamo: “Purezza e pericolo” del 1966 e tradotto in italia nel 1975 dalla società editrice “il Mulino” di Bologna, in traduzione di Alida Vatta. Il titolo originale dell’opera è”Purity and danger. An analysis of Concepts of Pollution and Taboo”. Nell’opera l’autrice si propone di descrivere l’impurità come rito, di esporre il concetto di contaminazione in quelle che sono le sfere profane. Riprende la religione cristiana descrivendo gli ‘abomini’ adoperati nel Levitico. Scrive di miracoli e di magia, di mondi primitivi, di pericoli e di poteri. Delinea quali sono i contini esterni, ma anche le linee interne dei concetti sopra riportati. Fa emergere il sistema come qualcosa che è in guerra con sé stesso. Il sistema che viene distrutto, almeno concettualmente, e poi ricostruito.
La psicologia della Gestalt è utile anche in antropologia per descrivere un approccio culturale. La società, infatti, non equivale alla politica o al far politica. La Douglas utilizza anche i saggi scritti da Claude Levy-Strauss sulla linguistica strutturale applicata, che individua sia legami di sangue che i rapporti con la mitologia.
La religione ha infatti insita in sé una paura di fondo che diviene una paura strutturale. Tutto ciò fa conseguire un’inibizione della ragione. Per Ricoeur addirittura l’impurità stessa è appena una rappresentazione, e per di più confusa in una paura specifica che blocca la riflessione. Con l’impurità, sempre secondo lo stesso autore, si entra nel regno del terrore.
In alcune culture primitive gi antropologi non hanno trovato tuttavia tracce di paura. Come nella regione dello Zande, in Sudan. Per gli zandesi le maledizione, ad esempio, non sono un raggiro, e chi crea problemi viene banalmente ignorato.
Nella nostra società il concetto di sporco si lega a quello di disordine, e quello di ordine a quello di pulizia. Quando puliamo infatti, non abbiamo paura dele malattie, e adattiamo positivamente l’ambiente a delle idee, le nostre. La contaminazione è strumentale, si crea in base a credenze e soprattutto a pressioni socieli. Per questo che la contaminazione diventa un pericolo, e la natura dello stesso è morale oltre che, appunto, sociale. Ha poco a che vedere, dunque, con le leggi della natura, e molto ha invece di che rapportarsi colle posizioni sociali. La contaminazione altro non è che una reazione all’anomalia. La sporcizia, o meglio, ‘idea di sporcizia, nasce dalla religione, dalla filosofia. Se noi siamo in grado di riconoscere la sporcizia è perché su di lei(e sul concetto di pulito) applichiamo l’idea della contrapposizione tra la vita e la morte, dell’essere e del non essere. Ed ecco che l’impurità diviene un rito.
Noi possiamo pensare lo sporco in quanto abbiamo presente l’amore per la pulizia e il rispetto delle convinzioni sociali. Ma a volte lo sporco è apprezzabile, si pensi all’esaltazione che ne faceva Santa Caterina, ma è così soltanto quando se ne conoscono le cause.
Il tabù, e dunque il terrore, nascono dalla morale e dalla religione primitiva. Per Emile Durkheim addirittura farebbe parte delle forme elementari della vita religiosa, e Robertson Smith, antropologo, non può che trovarsi d’accordo, scrive: “La religione era fatta di una serie di atti e cerimonie, la corretta osservanza delle quali era necessaria o auspicabile per garantire il favore degli dei o per scongiurare la loro collera; e per ogni membro della comunità era stabilita la misura della partecipazione all’osservanza di esse, sia per essere nato in seno alla famiglia o alla comunità, o in virtù della posizione che era giunto a ricoprire nell’ambito della famiglia o della comunità… La religione non esisteva per la salvezza delle anime, ma per la conservazione e per il benessere della società… Un individuo nasceva con una determinata relazione con certe divinità, altrettanto sicuramente quanto veniva al mondo con una relazione con i suoi compagni; e la sua religione, cioè quell’aspetto del comportamento che era determinato dalla sua relazione con gli dei, era semplicemente una parte dello schema generale di condotta che gli era prescritto nella sua posizione quale membro della società… La religione antica non è che una parte dell’ordine sociale generale che abbraccia dei e uomini allo stesso modo”.
Per Talcott Parsons Durkheim sarebbe tuttavia in controversia con gli antropologi inglesi. Per Herbert Spencer non bisogna fare una teoria utilitaristica, e secondo il sociologo la psicologia individuale non è utile alla società. Anche Gustav Le Bon(1841-1931) non concorda. Per il filosofo Hegel, poi, la morale raffinata implica una civiltà progredita. Ma per tornare allo scrittore Frazer, questi disprezza la società primitiva. Ciò fa emergere la sua ingratitudine nei confronti del selvaggi, un nostro debito che è generalmente riconosciuto.
Ma che cos’è la contaminazione nella sfera profana? Anzitutto è bene distinguere e, anzi, comparare le religioni al materialismo medico per capire il tema dell’igiene nei rituali. Ad esempio l’usanza di lavarsi le mani prima di mangiare ha permesso agi ebrei di essere immuni alle pestilenze. Tuttavia anche questo può servire a sottolineare i benefici ‘secondari’ dell’atto rituale, ma non spiega l’origine del fenomeno stesso. Padre Lagrange si esprime sull’argomento: “L’impurità dunque, non lo neghiamo, presenta un carattere religioso, o almeno tocca pretese soprannaturali; ma alle sue origini è forse diversa da una misura di prevenzione sanitaria? L’acqua non è forse qui un sostituto degli antisetticidi? E lo spirito temuto, non ha forse fatto dei danni propri alla sua natura di microbo?”. L’antropologo Harper scrive sul popolo degli Havik che “I cibi vengono distinti in cotti e crudi a seconda se siano o meno portatori di contaminazione. Il cibo cotto, a differenza di quello crudo, può trasmettere la contaminazione: così i cibi non cotti si possono prendere dalle mani dei componenti di tutte le caste o possono da questi essere manipolati – una norma necessaria dal punto di vista pratico di una società in cui la divisione del lavoro è correlata al grado della purezza ereditata. La frutta fresca e quella secca, finché è intera, non è soggetta alla contaminazione rituale, ma una volta che una noce di cocco è rotta o una banana è tagliata, un Havik non può accettarla da un membro di una casta inferiore”. Nel popolo Havik, inoltre, il terreno non porta e non trasmette ‘madi’, ovvero la purezza. Ma ad esempio nella società indiana, e quindi nei bramini il terreno può contaminare ed essere contaminato. E’ proprio qui che il concetto di impurità assume un significato anomalo ed ambiguo.
Nel Levitico viene proibito agli uomini(cristiani) di mangiare alcuni animali(“Non mangiate nulla di abominevole(…)), negando di fatto ai credenti di cibarsi di animali non ruminanti o dallo zoccolo spaccato. E’ vietato anche solo toccare queste carni. Non si possono inoltre assaggiare animali con piume. Sono queste norme arbitrarie con intento disciplinare, e non dottrinale. Una norma curiosa, che Stein spiega così “Il pesce con pinne e squame, ammesso dalla legge, simboleggia la resistenza e l’autocontrollo, laddove quello proibito viene trascinato via dalla corrente, incapace di sopportane la violenza. I rettili, che si avvolgono nelle loro spire, strisciando sul ventre, rappresentano le persone sempre dedite ai loro cupidi desideri e passioni. Le creature che si muovono sul terreno con le zampe al di sopra dei piedi, comunque, in modo che possono fare dei balzi, sono pulite, perché rappresentano il successo degli sforzi morali”.
Il rito è formato da una credenza e da un’applicazione pratica. Sono incluse la magia, la stregoneria, il destino, il sortilegio. Il rito è fatto da mutamento e da pressione.
E’ possibile dominare un pericolo: questo è un rituale che sa separare dalla situazione precedente in modo da operare una transazione per giungere ad un ‘nuovo status’. Tuttavia sono da prendere in analisi alcune controindicazioni, che possono essere ad esempio delle cerimonie di iniziazione che risultano mortali, un rituale di segregazione, punizioni varie, magari addirittura soprannaturali. Dunque esistono due forme di potere: quello controllato e quello incontrollato. E ciascun potere può essere anche esterno oppure interno, ovvero non necessariamente provocato dall’agente.
Quali sono i confini esterni? Il principale è indubbiamente la società, che è un’immagine potente: ha diritto al controllo e ha il potere si spingere all’azione. Nessuna credenza, secondo la Douglas, è troppo bassa da non potere essere assunta a rituale. Per Bruno Bettelheim il rituale è inevitabilmente legato all’orientamento tecnicistico della civiltà. Una cultura primitiva, infatti, è prodotta da incapaci ed immaturi: “Se le popolazioni pre-alfabete avessero avuto una struttura della personalità complessa come quella dell’uomo moderno, se le loro difese fossero state altrettanto elaborate e la loro coscienza così raffinata ed esigente, se l’interrelazione dinamica tra ego, superego ed io fosse così intricata, e se il loro ego fosse così ben adattato a scontrarsi con la realtà esterna e a modificarla, allora esse avrebbero sviluppato delle società egualmente complesse, per quanto, con ogni probabilità differenti. Le loro società sono comunque rimaste piccole e relativamente impotenti ad affrontare ‘ambiente esterno. Può essere che una delle ragioni di questo sia la tendenza che hanno questi popoli a tentare di risolvere i problemi con una manipolazione autoplastica invece che allo plastica”.
Ricorrente, nell’analisi del concetto di impurità, vi è quello dell’impulso genitale. In primo luogo la defecazione e il carattere magico che gli escrementi assumono nelle culture primitive. Per Mary Douglas tutto questo in antropologia assume un aspetto minoritario nelle culture oggi esistenti. Tuttavia una possibile spiegazione può essere quella della fuga dalla realtà nei primitivi, che tuttavia l’antropologia non riconosce siccome le fantasie erotiche dei bambini sono in realtà incompatibili e si è portati a fronteggiare l’esperienza, dunque alla sofferenza e alla perdita. In etnologia questi sono detti i paradossi dell’esistenza.
Insomma la contaminazione non ha punti di tangenza con la morale, come invece ne ha indubbiamente la religione, come emerge anche nel codice culturale da Mary Douglas realizzato e che qui viene riportato(il codice si riferisce alla società dei Nuer):
Quando una situazione viene considerata moralmente negativa, la credenza nella contaminazione può fornire una regola per determinare post hoc se l’infrazione abbia avuto luogo o meno
Quando i principi morali vengono a conflitto, la regola di contaminazione può essere fonte di chiarezza, semplicemente offrendo un punto di riferimento
Quando un’azione è considerata moralmente sconveniente ma non provoca l’indignazione morale, il credere alle dannose conseguenze della contaminazione può avere l’effetto di aggravare l’entità dell’offesa, e in questo modo di guidare ‘opinione pubblica dalla parte del giusto
Quando l’indignazione morale non viene sostenuta da sanzioni pratiche, le credenze nella contaminazione possono costituire un deterrente per i contravventori
Sacro e impuro sono due concetti non conciliabili. Finché l’identità è assente non può essere pericolosa. E per la gerarchia dei valori(che è materiale) sono drammatici il paradosso e la contraddizione.

















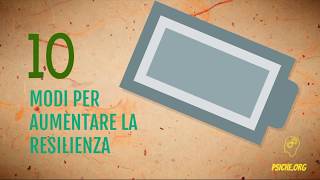
Commenti