Sul racconto autobiografico: concetti e terapie
- 13 ago 2017
- Tempo di lettura: 7 min
Cos’è un’autobiografia? Come si scrive?
“Oh, essere un libro! Un libro che viene letto con tanta passione!”
Elias Canetti
Si apre con questa citazione del linguista E. Canetti, autore celeberrimo de “La lingua salvata”, anche il saggio scritto da Duccio Demetrio: Raccontarsi, l'autobiografia come cura di sé(1997).
Demetrio ha fatto dell’autobiografia il suo cavallo di battaglia(come si intuisce anche dal nome dell’università di cui è rettore, ad Anghiari). Secondo il filosofo, infatti, arriva sempre un momento, quando si è adulti, in cui si sente l’esigenza di raccontare la propria storia di vita, ed è possibile farlo sia in forma scritta che oralmente. Pensare autobiograficamente significa proprio fare ordine dentro di sé, aiutarsi nella comprensione del presente, ma anche del passato: ritrovare ciò che è stato perduto, a partire dalle emozioni. Insomma descrivere il passato per trovare il proprio presente, provare gratitudine verso qualcuno o qualcosa, scoprire di avere dimenticato alcuni eventi o alcune persone. Il pensiero autobiografico ha il dovere di sorprendere: è ciò che si è realizzato, le proprie sofferenze, i propri amori. Tutto questo prende forma e, se il lavoro è compiuto correttamente e con il dovuto impegno, lascerà di sasso chi lo racconta, che vuole lasciar traccia di sé al futuro, per evitare l’oblio in previsione della sua futura dipartita. Insomma il pensiero autobiografico ha bisogno di coraggio, certo, ma anche di metodo, per procurare benessere. Il pensiero biografico si può quindi descrivere come l’insieme dei ricordi della vita trascorsa. Chi scrive o racconta sente quel che ha vissuto e si riconcilia con la propria realtà interiore e col proprio passato.
La riappacificazione, la compassione e la malinconia che si provano esaminando il proprio passato e permettono l’emergere della propria ‘individualità’. Lo stesso egocentrismo può permettere di rilasciare tracce benefiche nell’altruismo dell’anima. Evocare i ricordi significa svolgere il proprio lavoro autobiografico. Per Proust raccontarsi significava proprio sviluppare i ‘negativi’ della propria vita. Le emozioni, la lontananza, la memoria, ma anche l’indulgenza, la severità, la colpa, il senso di sazietà emergono durante il proprio racconto. Infine si dimentica: ogni giorno decadono miliardi di neuroni.
Durante la propria esposizione emergono alcuni ‘io’: l’io demiurgo, che significa interrogazione autobiografica, e l’io dominatore, il quale consiste nel cosiddetto ‘adulterio’ psicologico, appunto, dell’io dominatore, nonché il desiderio di coerenza, che può generare –se manca- frustrazione. Non sono da dimenticare neppure l’io necessario e l’io tessitore. Proprio quest’ultima personalità permette di collegare ed intrecciare gli eventi tra loro di modo da favorire la coerenza.
C’è un concetto importante nell’autobiografia: la ‘bella vita’, l’idea positiva di vita vissuta come andava vissuta, cioè bene, ideale che può andare a creare la passione autobiografica, nonché la cura di sé: è qui che le proprie memorie si riappacificano. Una volta svolto questo processo si può tornare a vivere, ed è favorito anche un ritorno alla crescita. L’autobiografia è un viaggio formativo a conclusione di un ciclo di vita, è autoformazione.
Durante il pensiero autobiografico è inevitabile svolgere retrospezione; significa evocare, ripensare, rimembrare(ovvero ricollocare nel posto giusto). Ciò fatto è possibile interpretare la propria vita vissuta, esprimersi, ed eventualmente giudicare: fa tutto parte del processo di riconciliazione. Riportare al presente, e quindi alla narrazione il proprio vissuto può provocare la sensazione psicologica della sazietà. In altri casi dell’insaziabilità(del vivere. In questo stato l’individuo crede e percepisce di non potere essere saziato fino ad avere vissuto tutto).
Il ricordo, nel lavoro autobiografico, non ha data, ma soltanto stagione. La fine di un periodo(o stagione come è stato definito poc’anzi) provoca una frattura. La più famosa –e quella a cui praticamente nessuno riesce a sfuggire – è quella dell’adolescenza, che si viene a creare per il neo-presente desiderio di indipendenza. Un tentativo del proprio sé di adultizzazione. Al termine dell’età adulta, invece, è tempo di bilanci, di variazioni di stile. Per Hermann Hesse: “E quando in certe anime particolarmente intelligenti e delicatamente organizzate balena l’intuizione della loro molteplicità, quando, come fa ogni genio, esse infrangono l’illusione dell’unità personale e sentono di essere pluriformi, di essere un fascio di molti ii, basta che lo dicano e tosto la maggioranza li imprigiona, ricorre all’aiuto della scienza, fa constatare la loro schizofrenia(…). In realtà nessun io, nemmeno il più ingenuo è un’unità, bensì un monto molto vario, un piccolo cielo stellato, un caos di forme, di gradi e situazioni, di eredità e possibilità(…)- Come corpo ogni uomo è uno, come anima mai”. Se per lo scrittore tedesco il proprio pensiero permette di giungere alle conclusioni più generali qui sopra ricordate, per il poeta italiano Francesco Pessoa l’esperienza è tutta personale, e, infatti, è scritta in poesia: “Se ricordo chi fui, diverso mi vedo/ e il passato è il presente della memoria. / Chi sono stato è qualcuno che amo,/ ma soltanto nei sogni(…)/ Nulla se non ‘istante mi riconosce. /Nulla il mio stesso ricordo, e sento/Che chi sono e chi sono stato/sono sogni differenti”.
A volte ci si concede una tregua autobiografica, in particolar modo può accadere in conclusione di un percorso di vita. Al termine di questo percorso il ‘detective interiore’(come è definito da Demetrio Duccio in Raccontarsi) può provare pentimento, può ‘sentire’ di essere stato sincero(assolutamente) e può anche avere un ravvedimento(si parla dunque di ‘ravvedimento tardivo’): si è conclusa la propria conversazione intima e personale, in cui la nostra verità non equivale ad una parola scritta o ascoltabile; questo può dare spazio a fraintendimento, insoddisfazione. Quando poi la sofferenza è eccessiva, si verifica il fenomeno del riseppellimento dei ricordi.
Esiste anche il cosiddetto esercizio immaginativo della solitudine, che corrisponde all’’otium’ degli antichi. In greco: “Epimeleston canton” ovvero “Occupati di te stesso”, prenditi del tempo per la solitudine, per oziare(nel senso desueto del termine) e riflettere su te stesso. Per i latini il concetto era quello della ‘pietas’, non degli altri ma di sé.
Ricordare è uno sfogo interiore, ricordare è qualcosa di bello e di giusto, un ‘gaudium’ con aggiunta di ‘laetitia’, un’arte dell’esistenza. Come sostiene Demetrio e una tecnica dell’essere. Per Michel Foucault, filosofo francese: “l’intensità dei rapporti con sé, cioè delle forme nelle quali si è chiamati ad assumere sé stessi come oggetto di conoscenza e campo d’azione, allo scopo di trasformarsi, correggersi, purificarsi, edificare la propria salvezza”. Sempre secondo il francese, ma in riferimento a Seneca: “Solo gli spiriti tranquilli e sereni possono ripercorrere ogni istante della propria vita, mentre quelli sempre carichi di impegni, come fossero sotto un giogo, non possono voltarsi a guardare indietro(…). La loro vita, dunque, si perde negli abissi del tempo(…) non ha alcuna importanza la quantità di tempo concesso se non ha un luogo per raccogliersi, ma passa attraverso delle vite sconnesse e incapaci di trattenerlo”.
Possono verificarsi, nel pensiero autobiografico, anche i seguenti quattro fenomeni: la trasfigurazione del ricordo, la ricomposizione(nonché il potere comunicativo), l’alleggerimento, che significa anche essere artefici di sé stessi, significa rivisitare il concetto di ‘invenzione’. E’ proprio su questo terzo punto che si fonda il patto autobiografico tra autore, protagonista ed eventuale attore. L’ultimo fenomeno è quello della spersonalizzazione, sulla quale Jerome Bruner scrive: “Uno dovrebbe, almeno credo, terminare un'autobiografia cercando di delineare che cosa intende per 'se stesso'. In effetti è un'impresa disperata, perché nel momento in cui ci si mette a pensare al problema appare chiaro che i confini della personalità si dileguano come neve al sole”. Proust invece, sullo stesso concetto, rimane un po' più distante: “Non è dal basso, nel tumulto della via e nella ressa delle case circostanti, ma quando ci si è allontanati, dai pendii di un poggio dei dintorni a una distanza da cui tutta la città è scomparsa o non forma più, rasoterra, che un ammasso confuso, nel raccoglimento della solitudine e della sera, che si può valutare, unica, persistente e pura, l'altezza di una cattedrale”(Da la ricerca del tempo perduto, volume VII 'il tempo ritrovato').
Per Oliver Sacks quando i ricordi iniziano a svanire, si può iniziare a comprendere ciò che la nostra vita è. Insomma, l'oblio che abbiamo precedentemente citato, il ricordo come frammento d'esistenza diventa un segno per comprenderci. Anche una cosa che non si ricorda concorre nell'effetto benefico di raccontare la propria vita vissuta. Questo accade, più in generale, perché l'intelligenza retrospettiva socializza coi ricordi. Codesto momento è chiamato 'istante cognitivo'.
Raccontare sé o raccontare le imprese degli altri era qualcosa di molto ricorrente nelle letterature degli antichi: si pensi alla lingua latina ed ai suoi generi delle memorie, delle lettere, dei commentarii, delle orazioni. Ma la vera svolta giunge con Rousseau e la sua 'Sutura Autobiografica' in cui scrivere diventa una medicina contro l'oblio del vissuto. Nell'autobiografia, infatti, ricordare significa riflettere e la retrospezione diventa automaticamente introspezione. Tutto ciò concorre in quello che in psicologia è detto feticismo autobiografico: collezionare ed accumulare ricordi.
E' opportuno aggiungere qualche parola su Marcel Proust, il quale riteneva che il passato lo si riassapora a poco a poco, e non tutto assieme. E proprio su questo concetto ha costruito la sua opera monumentale, nonché la più famosa e, probabilmente, la più ampia mai scritta in assoluto nella storia delle letterature mondiali, la 'Recherche'.
“Queste resurrezioni del passato, per quell'istante che durano, sono così totali da non costringere soltanto i nostri occhi a non vedere più la camera che ci sta intorno, per guardare gli alberi lungo i binari o a marea che sale. Costringono anche le nostre narici a respirare l'aria di luoghi lontani(...) nello stordimento di un'incertezza simile a quella che si prova a volte davanti ad una visione ineffabile quando si sta per prendere sonno”
“Avevo creduto di conoscere perfettamente il fondo del mio cuore. Ma la nostra intelligenza, per grande che sia, non può cogliere gli elementi che lo compongono, e che rimangono insospettati finché, dallo stato volatile in cui si mantengono per la maggior parte del tempo, un fenomeno capace di isolarli non li abbia sottoposti ad un principio di solidificazione”
“I legami fra un essere e noi non esistono che nel nostro pensiero. L'affievolirsi della memoria li allenta(...) è da soli che esistiamo. L'uomo è l'essere che non può riuscire da sé, che non conosce gli altri se non in sé”
Ma come si scrive un'autobiografia? Duccio Demetrio individua tre parti fondamentali: un inizio, ovvero un incipit, in cui viene esposto il cominciare di una vita, di un'esperienza; lo sviluppo, il ruit, ovvero lo scorrere; e la conclusione, exit, cioè la fine. In particolare esistono due tipi di incipit: quello sensoriale(E' il caso dell'autobiografia di Elias Canetti) e quello figurativo, ovvero scenico(Che ritroviamo in Elsa Morante e in Jacques Prevert). L'incipit è origine del ruit. Dopo l'exit è possibile rileggere quanto scritto. E proprio in quest'ultimo caso Lalla Romano, la celebre autrice di 'Una giovinezza inventata' scrive: “Ho ripreso in mano il mio libro, l'ho aperto qua e là. E' quasi insopportabilmente vivo. Però, pur essendo così appassionato è un libro di pensiero, La sofferenza e anche l'allegria, il divertimento, sono contrappuntati da pensieri. Reazioni mentali che sovrappongono il mio mondo interiore al suo(Quello del figlio dell'autrice)”. Tutti possono esercitare il pensiero autobiografico perché, come afferma ironicamente anche M. Scheneider, tutti abbiamo una biografia e una matita.
Insomma, un testo senza correzioni, senza dubbi, senza esitazioni è un testo senza autore. Se il testo è riflettuto e ben ponderato, al termine dello stesso, si prova quella che Demetrio definisce 'Un'acerba verità', quella dell'autobiografia conclusa. Nietzsche la definisce come un 'ritrovarsi dopo essersi persi'.

















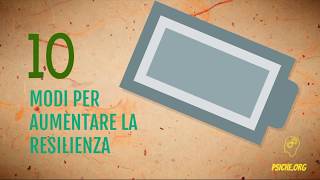
Commenti