Sulla didattica interculturale
- 17 lug 2017
- Tempo di lettura: 8 min
Negli ultimi decenni la scuola si è popolata di persone di inedita provenienza: l'est europeo, il Maghreb, l'India e il Bangladesh, fino ad arrivare ai più disparati paesi del globo. E gli stranieri novelli si trovano alle prese con la lingua italiana, con una nuova cultura, spesso con una nuova religione, un nuovo ambiente e una classe di facce sconosciute. Non solo, i prima citati compagni si ritrovano con un nuovo elemento(Con diverse differenze, talvolta visibili anche esteticamente) tra di loro, che riesce a stento a comunicare con qualche parola nella loro lingua, oppure tace. E non finisce qui: tutti gli insegnanti che entreranno in aula dovranno proseguire i loro programmi e le loro lezioni con i vecchi alunni e il neofita, che lo guarderà con curiosità, senza capire le parole che gli vengono rivolte. E' evidente che l'Italia(E il resto dell'occidente) si ritrova d'innanzi ad un bel problema: integrare gli alunni nel gruppo e far sì che il gap venga presto colmato, per non far rimanere troppo indietro il resto della classe. Mettiamo ora che non solo vi sia un nuovo alunno straniero, ma che ve ne siano dieci, provenienti da continenti diversi, che parlano lingue diverse e che provengono da contesti sociali differenti. La situazione si complica inesorabilmente. Dunque ci ritroviamo d'innanzi ad un problema pedagogicamente rilevantissimo, a cui approcciarsi celermente per gestire al meglio questa situazione. Già nel 2002 Duccio Demetrio, filosofo presso l'università Bicocca di Milano e direttore della Libera Università di Anghiari, oltre che della rivista “Adultità”, e Graziella Favaro, membro della commissione nazionale Educazione Interculturale del Ministero della Pubblica Istruzione e consulente pedagogica del Centro “Come” di Milano, si attivano scrivendo un volume: “Didattica interculturale, nuovi sguardi, competenze, percorsi”, proponendo anzitutto una presentazione della situazione interculturalità(Con enorme attenzione nell'utilizzo dei termini corretti).Il libro propone infatti la riflessione riguardo alle differenze culturali da promuovere; questo infatti sarebbe il mezzo migliore per giungere ad un “orizzonte progettuale comune”. Gli autori erano già impegnati su questo fronte: nel 1992 pubblicano”Immigrazione e pedagogia interculturale” e nel 1997 pubblicano “Bambini stranieri a scuola”. Demetrio scrive anche “Agenda interculturale” e “Bambine e bambini di qui e d'altrove, “Il mondo in classe” Alfabeti intercultrali”, “Insegnare l'italiano agli alunni stranieri. Dei metodi L'opera dei due autori ha alcuni modelli di riferimento, come le teorie etnopedagogiche di Abdallah-Pretceille(1999) e di Edgar Morin. Si mettono subito in chiaro i cinque obiettivi di individualità e didattica teorizzati da Alessandra D. Allegra nel 1993: Conoscenza di sé ed identità Relazioni di amicizia Vivere senza troppe certezze. La ricerca continua. Superamento dell'etnocentrismo Sapere studiare ogni cultura L'alunno deve essere dunque guidato a prendere conoscenza fisica e psicologica di sé e a formare una vera e propria identità. E deve essere libero di poterlo fare. E' necessario favorire le relazioni di amicizia all'interno del gruppo classe, di modo che l'apprendimento possa essere sereno e, talvolta, collettivo. Bisogna guidare lo studente a vivere senza troppe certezze. E' giusto averne alcune, ma se ne sono presenti troppe, il rischio è quello di arrestare la ricerca, che è invece strumento base dell'apprendimento e deve essere continua. Compagni vecchi e nuovi, provenienti da contesti culturali differenti devono essere esortati a superare l'etnocentrismo, che talvolta è stato inculcato loro, di modo da essere disponibili ad accogliere le altre culture. Infine è il caso che si pongano le condizioni necessarie allo studio della cultura, chiarire il concetto stesso di “cultura”, guidare al rispetto e alla conoscenza del diverso, con interesse e senza timore alcuno. Hiang-Chu Ausilia e M. Checcin propongono invece i tre approcci fondamentali, che propongo qua di seguito: Compensazione ed assimilazione Integrazione Intercultura Dove la compensazione prevede l'utilizzo della pedagogia per stranieri e propone la questione delle classi sperimentali, o addirittura quelle a contenenti soltanto alunni di provenienza non italiana; dove l'integrazione prevede l'apprendimento di una nuova cultura, ma non solo: è consigliabile coltivare anche la propria; e dove per intercultura si intende la valorizzazione e l'autopromozione delle nuove culture di cui si viene in contatto e della propria. Andrea Semprini scandisce poi due differenti tipi di epistemologia, appunto, quella interculturale e quella monoculturale, rendendo evidenti i vantaggi della prima. Ma in che cosa consiste, per gli autori, il coraggio interculturale? Anzitutto nell'utilizzo dell'etnopedagogia(Con i sopra citati metodi, ma anche con la curiosità, e, nel caso, con la sperimentazione di altri modelli. E' inoltre opportuna la mediazione e la negoziazione delle inferenze, di modo da creare un clima scolastico sereno. Esistono competenze plurali: oltre alla già citata etnopedagogia, sono competenze plurali anche il cognitivismo(E la relativa scuola di psicologia) e l'ecologia, in quanto l'ambiente è parte integrante e fondamentale nell'apprendimento. La scuola è inoltre un luogo dove gli studenti possono raccontarsi ed essere raccontati dagli altri. Duccio Demetrio dedicherà un intero volume a questo argomento, nella più ampia prospettiva autobiografica, “Raccontarsi, l'autobiografia come cura di sé”. Tale azione è utile anche etnopedagogicamente: permette agli studenti di raccontare il proprio vissuto, che sia della precedente giornata o ben più lontano. E può essere uno strumento assai utile per la conoscenza di nuove culture, oltre a favorire l'acquisizione di importanti competenze dialogico-narrative agli studenti. M.Sclavi, nel 2000, riassume in sette punti quella che lui definisce “L'arte di ascoltare”: Niente fretta di concludere Devi cambiare punto di vista Dare ragione agli altri per immergersi nella loro prospettiva Dare centralità alle emozioni L'ascoltatore è un esploratore L'ascoltatore accoglie i paradossi e li gestisce creativamente Usa l'umorismo! Mediazione ed educazione Edgar Morin elabora la teoria de “I sette saperi”, ovvero il come insegnare la comprensione per essere solidali e morali. Dalla pedagogia educativa si giunge dunque presso l'educazione interculturale operativa, ovvero ad una metodologia strategica in cui è dato ampio spazio e valore all'educazione e alla spontaneità, cosa che negli anni Settanta, razionali come furono, era impossibile pensare, come ci tiene a sottolineare Demetrio nel 1998. Possiamo riassumere il nuovo approccio in tre punti essenziali: La pedagogia è politica ed educazione interculturale La scuola in tal modo diviene un vero e proprio laboratorio sociale Inizia ad esistere la cosiddetta Filosofia Compensativa, la quale pone l'intercultura come principio obbligatorio e non circoscrivibile in alcun modo: l'intercultura non è contingente. La pedagogia compensativa non valorizza di per sé ciò che il bambino straniero ha da dire, creando di fatto un vuoto sia linguistico che culturale. La soluzione esiste nella formazione interculturale. Per applicare tale modello è necessario dapprincipio delineare le strategie e comunicarle. Realizzare quindi veri e propri progetti di incontro. Chiaramente però bisogna allontanarsi dal pericolo, costituito dall'auto-evidente razzismo e, più in generale, dal preconcetto. L'aggettivo “interculturale” può quindi essere inteso come interazione, come scambio, apertura a nuove culture. Ma è insita in lui anche la valenza di reciprocità, di solidarietà obiettiva. In esso vi è un riconoscimento di valori, di vite e di simboli. Da “interculturale” ha origine il sostantivo “Multicultura”, che è di per sé un termine neutro e descrittivo, ma se usato per contesti pedagogici assume un significato più ampio: è coesistenza di popoli. L'oggetto culturale di cui andiamo parlando è enorme:i bambini stranieri in Italia sono presenti in percentuali sempre maggiori, a Milano, dalle ultime statistiche, erano il 21,3%(In una classe di 20 persone, in media, 4\5 sono straniere). Le normative esistono, talvolta non si applicano, ma ci sono, e prevedono una serie di applicazioni pratiche(Dal 1990): Italiano come L2, ovvero seconda lingue. La lingua d'origine dello studente deve coesistere con la seconda. Utilizzo della figura del mediatore Utilizzo delle nuove tecnologie Dare centralità ai centri di intercultura Educare i ragazzi ai propri diritti Svolgere una funzione orientativa in un paese straniero Attività di recupero degli emarginati, o di chiunque si sia ritrovato in una condizione problematica Utilizzo di linguaggi artistici, ma anche ludici, che stimolano l'espressione e la fantasia dello studente Gemellaggi con scuole straniere, ed eventualmente addirittura i cosiddetti “scambi” culturali: alcuni studenti vengono spediti in una scuola straniera ed altri vengono accolti dalla scuola straniera. Un'esperienza che può essere utilissima anche ai ragazzi italiani Sviluppare il rapporto con le famiglie, a volte complesso e tortuoso, anche per gli auto-evidenti problemi linguistici. Dialogo tra religioni Sviluppare l'identità di genere, che concorre su più ampia scala alla creazione dell'identità del ragazzo L'utilizzo di alcune delle sopra citate soluzioni di intercultura e multicultura significa applicare l'etnometodologia in una scuola. Il termine fu coniato da Garfinkel e Schitz. Si rendono evidenti, con alcuni elementi di questa metodologia, delle verità narrative, che facilitano di fatto la comunicazione. Dall'etnometodologia ha origine l'etnopsicanalisi, per realizzare la terapia di immigrati, concetto che era già stato pensato addirittura dal padre della psicanalisi, Sigmund Freud, ma mai applicato appieno. Il relativismo culturale si va ad unire e a legare, dunque, coi dogmi psichiatrici, di modo da riconoscere una volta per tutte l'universalità di alcune patologie(E la non-esistenza delle razze) com'era stato teorizzato da F. Laplantine. Viene così applicato il concetto di social service, ovvero un modello di azione. Nel 1976 Le Bohec stabilì l'importanza delle biografie nella formazione, che si lega ai concetti di filosofia debole e di crisi dei fondamenti e tange inevitabilmente i paradigmi della complessità, e la scienza del singolare, nonché la stessa persona. Con l'autografia o con l'autobiografia si applica infatti la stessa epistemologia, vengono raccontate storie uniche e irripetibili, vengono narrati veri e propri “casi”. La condivisione di storie crea elementi di unione tra gruppi, e col tempo va a formare anche una storia, quella dei legami affettivi all'interno del gruppo. Si possono utilizzare essenzialmente due metodi biografici\autobiografici: la retrospezione, riguardo la narrazione del passato. Per quanto riguarda il presente, abbiamo l'introspezione, l'analisi del !qui ed ora”, come ama definirla Duccio Demetrio. Trovano qui applicazione anche le teorie di Bruner: è riconoscibile il soggetto epistemico, ma anche la psicologia culturale. L'alunno diviene ricercatore di sé stesso e viene applicata la pedagogia della memoria: viene stimolata l'individuazione collettiva, la ponderazione, la riflessione, addirittura la meditazione. Torniamo all'argomento filosofico e ad Husserl, ma anche ad Heidegger, i principali esponenti della corrente fenomenologico-esistenziale. Sono loro a dare una definizione del bosco dell'essere, luogo nel quale lo scientismo e il positivismo non esistono e lasciano posto all'umanità concreta, al “qui ed ora”. Binswanger, Sartre e Marcel arriveranno addirittura a parlare di passato e trascendenza. Secondo questa filosofia è impossibile gettare uno sguardo di insieme ad una situazione o all'umanità ed esiste il concetto di onnipotenza e di eideticità, che è la rappresentazione cognitiva di accadimenti ed esperienze, e che dà vita al relativismo culturale. Qui il simbolo ha un grande valore. Il sostantivo simbolo ha origine dalla parola greca “sumballein”, che significa “collegare”. Per Carl Gustav Jung il simbolo altro non è che un termine che non è rappresentazione. Significa formulare nel quotidiano con specifici accidenti. Per gli altri il simbolo rimane qualcosa di vago e di sconosciuto. Insomma, per semplificare quello che spiega magistralmente Jung possiamo dire che il simbolo è qualcosa di soggettivo. Infatti esistono eventi rimasti sotto la soglia della coscienza, non registrati con consapevolezza. La psiche si può considerare come una parte integrante della natura, e i suoi enigmi sono di gatto infiniti. La mediazione e l'intreccio di culture fan sì che si abbia un processo dinamico, che si crei un certo grado di porosità, nonché di stratificazione, fan sì che, per utilizzare l'immagine fornita da Demetrio, la cultura cammini sulle gambe delle persone. Con l'esperienza etnopedagogica, in conclusione, si realizza il progetto di relazione culturale e di consapevolezza; con l'autobiografia si stimola l'esplorazione della memoria. L'intercultura intesa pedagogicamente fa sì che si uniscano i pezzi del puzzle, rendendo beneficio sia agli alunni precedentemente presenti nel gruppo classe, sia a quelli nuovi. Come nella storia, narrata da Demetrio dei Ciechi e l'elefante, in cui ogni cieco tocca una parte dell'elefante e si ostina a definire il grande animale con gli attributi della parte che sta effettivamente toccando, senza curarsi di quello che dicono gli altri. Se il gruppo di ciechi riuscisse a credersi e a mettere assieme le cose, dopo essersi raccontati, tutti loro avrebbero in mente che animale sia davvero l'elefante. Insomma, senza la comunicazione, senza un approccio di questo tipo, la visione della realtà rimane relativa e, talvolta, come nel caso appena narrato, inesatta. “Sia l'occidente che l'oriente T'offron purezza da gustare Lascia i capricci, lascia il guscio Siediti al grande convito: fossi tu solo di passaggio Non puoi sdegnare questa coppa Chi sé conosce e gli altri conosce Anche qui deve riconoscere: Oriente e Occidente più non si posson separare Con sensi arcani fra i due mondi Cullarsi è cosa che mi giova! Così fra oriente e occidente Fare la spola sia del meglio”
Goethe

















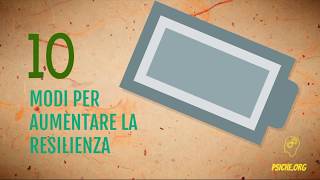
Commenti